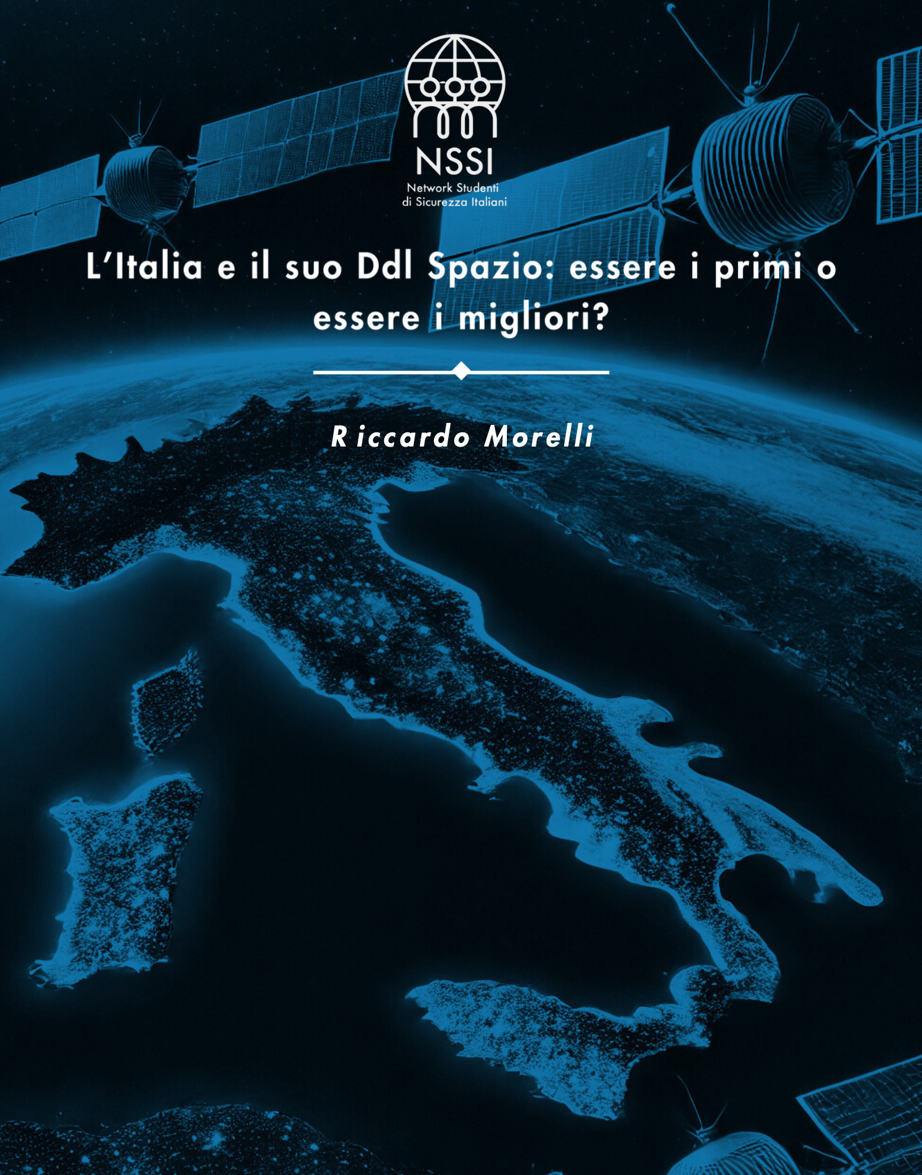
L'Italia e il suo Ddl Spazio:
Essere i Primi o Essere i Migliori?
Di Riccardo Morelli
1 aprile 2025
English version below
Abstract
Il Ddl Spazio, il primo Disegno di legge italiano sulla space economy, affronta un contesto geopolitico e normativo complesso, segnato da una rapida evoluzione del settore spaziale e da sfide globali inedite. Il Governo italiano è consapevole del ruolo che questo settore può avere sia per la Sicurezza Nazionale che per lo sviluppo industriale – si presenta così un dilemma tra azzardare una prima regolamentazione nazionale o attendere una legislazione europea più definita, con il rischio di rimanere indietro.
Introduzione
Il Ddl Spazio entra nella Camera dei deputati per la sua approvazione: la discussione è accesa e su di esso pendono le prime iniziative italiane per regolamentare uno dei settori a più alto sviluppo al mondo. L’Aula di Montecitorio però decide di approvare con 133 voti a favore (89 contrari e 2 astenuti) il primo Disegno di Legge sulla space economy. La palla passerà ora al Senato per la sua approvazione definitiva e rappresenterà, di fatto, il primo provvedimento legislativo, in ambito nazionale, diretto a regolamentare il settore.
Il tema è complesso, non ci sono commenti a riguardo. Al di là di come si voglia leggere il testo del documento, si tratta in ogni caso di un primo tentativo: ci saranno parti contente e altre scontente, solo il tempo ci insegnerà come potersi evolvere al meglio. Il settore che il Ddl cerca di definire è ancora tanto (forse troppo) opaco – non si riesce a dare una stima univoca del valore del settore spaziale. Gli attori in gioco sono molteplici e i player si distinguono in privati e pubblici. Non solo, gli stessi Stati rappresentano anche una delle categorie dei consumatori di queste tecnologie che trovano applicazioni sia civili che di intelligence. La distinzione non è secondaria: regolamentare un’attività privata in cui uno dei consumatori principali è lo Stato stesso, con fini di Sicurezza Nazionale, rischia di creare un circolo vizioso che porta ad un rallentamento autogenerato delle nostre capacità di controllo.
Questa analisi si prefigge dunque di mettere bene in mostra quale è il contesto, nazionale e internazionale, in cui il Ddl Spazio si inserisce senza avanzare giudizi affrettati su quali possano essere le sue evoluzioni.
Il contesto geopolitico
Per capire il Disegno di legge, dobbiamo fare un passo indietro a qualche anno fa. Nel post pandemia l’Italia ha visto avviarsi un gioco politico molto complesso che ha condotto il Governo Conte II alla sua fine per essere sostituito dal Governo Draghi (2021-2022). Proprio in questa fase il COPASIR pubblicò i risultati di una ricerca interna intitolata Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica indicando, nella premessa, le ragioni che hanno motivato lo studio: “Il Comitato ha ritenuto necessario condurre una specifica indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale, avviata in concomitanza con un’altra indagine conoscitiva, avete ad oggetto le prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence.” Tale relazione, come si evince proprio nelle prime pagine introduttive del Ddl, rappresenta la base fondante su cui il nuovo Governo Meloni (che ha delegato il Ministro Urso, Presidente del COPASIR al momento della relazione di cui sopra, ai temi dello Spazio in Italia) ha dimostrato la necessità urgente di creare una regolamentazione europea (e nell’attesa una interna italiana) nei temi dello spazio a tutela delle imprese e degli utilizzi di intelligence. La situazione economica italiana nel 2022 era contornata da una leggera ripresa dal post-Covid ma comunque ancora inferiore rispetto ai ritmi pre-pandemici. Nonostante questo, lo spazio non è mai stato messo in secondo piano, infatti, l’Italia è uno degli Stati più avanzati al mondo: è il terzo contributore dell’ESA (dopo Francia e Germania) e la sesta industria al mondo oltre ad essere uno dei pochi ad avere un’intera filiera produttiva nei propri confini. A ciò, si aggiungono anche avanzate competenze tecniche nella realizzazione di satelliti e nelle tecnologie di trattamento dei dati. Nonostante questo, nello spazio come in altri temi della nostra storia politica, l’Italia vive la paradossale dicotomia tra eccellenza industriale ed arretratezza burocratica – le giovani imprese rischiano di fallire ancor prima di poter diffondere i loro prodotti a livello internazionale; ormai però tutti gli analisti e tutti i politici, indipendentemente dall’orientamento, hanno ben inteso che questo, per il settore spaziale, non può accadere: è troppo importante. Il dominio Spazio sta aumentando sempre di più il suo ruolo a tutela della difesa e della sicurezza di Nazioni, territori, persone, ambiente e infrastrutture. Per tali motivi, si aprono sfide inedite non solo per l’ordine mondiale ma anche per la difesa Nazionale italiana. Il COPASIR, dunque, osserva che per l’Italia si presenta una sfida impegnativa che esige una riflessione sulle modalità alternative da impiegare nelle forniture delle infrastrutture e dei prodotti spaziali – bisogna tutelare le nostre imprese, creare un network europeo che non implichi una limitazione nei controlli di intelligence e bisogna limitare i rischi dei successi cinesi.
L’Italia però ha ben chiara l’importanza dello spazio già da prima del report del COPASIR del 2022, infatti, già la Legge dell’11 gennaio 2018 n.7 è intervenuta in un primo momento per aggiustare la governance dello Spazio. Grazie a tale legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri è affidata l’Alta direzione ed il Coordinamento delle Politiche Spaziali e aerospaziali dei Ministeri ed è stato, inoltre, istituito il Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT) – attualmente presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, quale autorità delegata dal Presidente del Consiglio, a cui si aggiunge, tra le varie figure, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Teodoro Valente.
Nel recente Dossier “Disposizioni in materia di economia dello spazio” viene esplicitata l’accelerazione indotta dal contesto geopolitico e geoeconomico. In particolar modo viene scritto che come il “rapido disaccoppiamento tra gli USA e la Cina […] (rafforzi) l’idea che stiano emergendo due blocchi mondiali dominanti, con un possibile ritorno ad una situazione di Guerra Fredda”. Il Ddl presentato alla Camera, dunque, deve essere letto tenendo conto di un’osservazione della situazione politica globale. Ad esempio, il passaggio dalla presidenza Biden alla presidenza Trump (ancora ignota al momento del Dossier) stravolge l’interpretazione fino ad oggi discussa del diritto internazionale perché non può esistere accordo, riunione o Trattato (da qui al prossimo futuro) che non tenga conto della prima economia mondiale. I quadri normativi regionali, come quello dell’Europa, potrebbero dunque guadagnare forza e tramutarsi in occasioni per acquisire un’autonomia nella speranza di una, futura, autosufficienza. Tali osservazioni potrebbero essere state proprio una delle ragioni del convincimento dei deputati ad approvare il Disegno di legge in questione. Il tema incerto della posizione della NATO e l’avvio di un’amministrazione americana anti-multilateralismo aprono le porte a nuovi scenari diplomatici, economici e industriali.
Per capire il contesto in cui si inserisce il Ddl Spazio e quali sono state le pressioni, dirette o indirette, che hanno spinto il Governo a voler presentare un Disegno di legge su un tema così in continua evoluzione, dobbiamo obbligatoriamente uscire dai confini nazionali del diritto. Guardando al palcoscenico mondiale, infatti, troviamo diverse anomalie che portano ad un sovraffollarsi di norme, alcune sottoscritte da molti Stati altre meno partecipate, che generano una forte confusione – è in questa confusione che i privati spingono l’acceleratore.
Partiamo dalla massima riconoscenza possibile, a mio parere personale, sulla rilevanza dello spazio nel mondo della Difesa: la NATO ha definito lo Spazio come il quinto dominio collettivo per il quale è possibile azionare l’articolo 5 del Trattato. Questo comporta quindi che le missioni Spaziali assumono una nuova importanza diplomatica (si parla di space diplomacy) sulla scia degli altri Trattati firmati nel corso della recente storia che compongono ciò che è noto come il Corpus Juris Spatialis. Lo Spazio, infatti, prima ancora di portare l’eccitazione del ritorno economico, ha generato forti paure nei policy maker del Secondo dopo guerra su quali potessero essere le possibili ripercussioni. Proprio per questo, già nel 1967 (due anni prima che l’Apollo 11 atterrasse sulla Luna) fu firmato il primo Trattato internazionale in materia di spazio noto come “Trattato Sullo Spazio extra-atmosferico” (Outer space Treaty) – questa prima regolamentazione prevede il divieto di collocare armi nucleari o ogni altro genere di armi di distruzione di massa nell’orbita terrestre, sulla Luna o su altri corpi celesti o comunque stazionarli nello spazio extra-atmosferico. Altri punti essenziali però dell’Outer Space Treaty sono il divieto di compiere test su armi di qualunque genere, condurre manovre militari o stabilire basi militari (installazioni o fortificazioni) e, inoltre, il divieto di rivendicare risorse poste nello Spazio, quali la Luna, un pianeta o altro corpo celeste. Già qui, facendo un piccolo spaccato sull’attualità, possiamo vedere la complessità giuridica di intendere l’estrazione mineraria di asteroidi per cui, su questa linea, ogni materiale acquisito sarebbe di “proprietà” del genere umano e non del privato o dello Stato che ha conseguito la missione.
Il Corpus Juris Spatialis
va a prendere una sua forma negli anni seguenti, con la firma di altri quattro trattati di cui l’ultimo, noto come Trattato sulla Luna, finalizzato a regolamentare le attività sul nostro satellite naturale come l’estrazione di materie prime, è stato ratificato da soli 18 Stati di cui, rilevante, è l’assenza di Stati Uniti, Russia e Cina.
Anche l’Unione Europea però ha ben chiara la rilevanza dallo spazio e non è un tema solo recente, come si potrebbe immaginare. Già dal 2009, con l’art. 189 del TFUE, si scrisse che l’unione Europea elabora una politica spaziale per “
favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue politiche”.
Il 2016 è stato l’anno in cui è stata lanciata la Strategia spaziale per l’Europa con lo scopo di spingere lo sviluppo industriale dell’UE con 4 punti principali:
- Incoraggiamento dell’uso commerciale per settore pubblico e settore privato di dati e servizi spaziali;
- Sostegno alla ricerca e all’innovazione;
- Rafforzamento dell’autonomia europea nell’accesso e nell’uso dello Spazio;
- Rafforzamento dell’Europa come attore globale in seno alla cooperazione internazionale
Onestà intellettuale ci porta ad osservare che tali obiettivi sono tanto interessanti quanto vaghi ma, spezzando una lancia a favore del Parlamento Europeo, dobbiamo riconoscere che al 2016 nessuno aveva ben chiaro quali sarebbero potuti essere gli sviluppi di questo settore. Basti pensare che il primo atterraggio in verticale di successo dell’americana SpaceX è avvenuto il 22 dicembre del 2015 e nove anni dopo siamo arrivati a vedere 138 lanci di successo nel solo 2024, con tutto ciò che tale risultato ha comportato. In via generale, l’Europa tenta di smussare il suo ritardo con piani a lunga gittata, promuovendo obiettivi e missioni a durate medio-lunghe così da non sovraccaricare le imprese e non destare troppo scompiglio alle amministrazioni nazionali; così anche per lo Spazio, nel 2021 è stata elaborata dal Consiglio d’Europa una rielaborazione della Strategia spaziale per l’arco temporale 2021-2027. Va ricordato però che tale arco temporale sta abbracciando dei radicali cambi di rotta politici in tutto il mondo. In America si è passati dall’amministrazione Biden a quella Trump che vede come alfiere Elon Musk al suo fianco, ma non solo. L’Italia ha visto inserirsi un governo decisamente più favorevole verso le missioni spaziali nonostante, storicamente, i partiti di centro-destra fossero i più ostili verso le spese in questo settore. Ancora su questa linea abbiamo avuto un cambiamento del Segretario Generale della NATO da Stoltenberg a Mark Rutte. A cui si aggiungono altri nuovi esponenti politici che stanno per prendere le redini dei loro paesi come in Germania, Groenlandia e Canada. Tutto questo accade senza parlare delle missioni spaziali che si sono realizzate in questo arco temporale: gli indiani che sono andati per la prima volta sulla Luna confermandosi una forte realtà tecnico-scientifica, i cinesi che hanno raggiunto per la prima volta la faccia nascosta della Luna oltre ai successi dei privati come è il caso di Starship di Elon Musk, possibile asso nella manica che gli USA potrebbero usare nella loro corsa contro la Cina. Ovviamente le dinamiche spaziali sono direttamente influite dalle tensioni geopolitiche e da quando è stato avviato il piano europeo nel 2021 il mondo ha visto l’inizio della guerra in Ucraina (2022), guerra a Gaza (2023) oltre al sempre teso confine con Taiwan.
Questo è il motivo per cui, in Europa prima che in Italia, bisogna sempre chiedersi: è sempre meglio arrivare primi? È appena scoccata la “metà” dell’arco temporale del piano spaziale europeo 2021-27 e queste sono le vicissitudini degli ultimi tre anni, eventi che in nessun modo potevano essere previsti e che però cambiano i bisogni dei consumatori, degli attori e le necessità regolamentari nazionali, europee ed extra-europee. Sarebbe ancora corretto rimanere ancorati a quelle decisioni?
Questo è il contesto in cui il Governo Meloni si trova e in cui ha deciso di fare la sua mossa: la proposta alle Camere del primo Disegno di Legge sulla space economy. Il rapporto politico-personale che il Presidente Meloni ha mostrato, nel corso degli ultimi tempi, con Elon Musk ha fatto intendere da subito come l’Italia stia cercando di costruirsi un suo ruolo di rilievo nel settore spaziale. Come abbiamo potuto osservare però, la governance di questa industria è complessa e intricata, oscillando tra i profitti dei privati e gli interventi dei Servizi Segreti con conseguente limitazione alla diffusione di informazioni strategiche.
In linea generale, non può esistere appassionato di spazio totalmente contrario ad Elon Musk dato che, se tali passioni hanno ancora un senso di esistere, è certamente imputabile anche alla sua visione, seppur a volte controversa, del mondo. Va fatto un diverso discorso, però, quando si esce dalla sfera mediatica e storica di Elon Musk per andare a guardare direttamente le sue aziende, le attività poste in essere e il potere che ad esse si rischia di delegare. Un esempio è il presunto accordo che la Meloni voleva creare con Elon Musk, in merito all’utilizzo dei servizi Starlink, che non è mai stato esplicitamente discusso nelle Camere. Tale prospettiva, ha certamente cambiato la sua rotta dopo l’incontro-scontro, di inizio marzo, tra il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump nello Studio Ovale. Non è questa la sede di analisi di questo incontro, ma va posto l’accento su una delle sue conseguenze al di là di qualsiasi posizione politica si abbia: Elon Musk ha minacciato il Presidente Ucraino di staccare i servizi forniti da Starlink, utilizzati dai militari ucraini, qualora Zelensky avesse deciso di non firmare l’accordo proposto dal Presidente americano. La strategia diplomatica è valida, ad essere anomala è la modalità – si tratta di un privato, nei confronti di un Presidente, in grado di orientare l’andamento di una guerra. Il resto, come si dice, è storia con la conseguenza che l’Ucraina ha perso le posizioni nel Kursk (Russia), che conquistò tempo addietro in una situazione di incertezza, e che avrebbe voluto utilizzare, in una situazione di tavolo di pace con il Presidente russo Putin, come elemento di scambio o, in ogni caso, posizione a suo favore.
Ecco che qui ritorna quindi attuale il titolo di questa analisi; non possiamo sapere se utilizzare i servizi Starlink per il Governo italiano sia, o sarà, una mossa strategicamente efficace ma certamente non potremo sorvolare, nelle valutazioni future, quelli che sono stati i recenti eventi.
Tutto ciò rappresenta quindi il contesto, in cui questo Disegno di Legge cerca, a modo suo, di entrare per la prima volta. Nella stessa apertura del Ddl si esprime il ruolo del cambiamento di paradigma generato dall’ingresso dei privati che, come si scrive, “segna un mutamento di passo anche nella regolazione, che dal diritto pubblico internazionale scende a permeare il diritto pubblico nazionale e il diritto privato”. Ciò comporta che qualsiasi valutazione si voglia effettuare sulle singole norme, è nulla in un settore così mutevole e solo il tempo potrà insegnarci come indirizzare la nostra legislazione in materia.
Il Ddl Spazio – elementi principali
Ora, dato il contesto presentato, vediamo quali sono i punti principali del Disegno di legge. Per analizzare nel dettaglio la sua struttura, possiamo partire dal parere della I Commissione Permanente per gli Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni per vedere quali sono le sfere di interesse che, a suo avviso, vengono toccate dal Ddl: “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, “difesa e Forze armate”, “sicurezza dello Stato”, “tutela della concorrenza”, “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”. In tale rapporto si evince chiaramente che “obiettivo del provvedimento, costituito da 31 articoli divisi in cinque titoli, è quello di colmare il vuoto normativo nell’ordinamento nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell’industria spaziale italiana e l’innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale”.
Analizzando sempre però i pareri delle Commissioni permanenti è interessante osservare la premessa della II Commissione Permanente sulla Giustizia, la quale riconosce il tema di interesse [del Ddl] come crocevia strategico degli interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Osserviamo, inoltre, che né la VI Commissione Permanente (Finanze), né VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione) né la IX Commissione Permanente (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) hanno espresso considerazioni votando favorevolmente al Disegno di legge (così come le altre Commissioni). L’obiettivo, dunque, è molto chiaro e il Governo Meloni si prefigge di conseguirlo su cinque piani di interesse:
Titolo I (artt. 1-2):
disposizioni generali in materia di spazio;
Titolo II (artt. 3-14):
si identificano i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’autorizzazione all’esercizio di attività spaziali. Sulla stessa linea vengono quindi definiti l’apparato delle sanzioni amministrative e penali sul relativo procedimento;
Titolo III (artt.15-17):
focus sull’immatricolazione degli oggetti spaziali;
Titolo IV (artt. 18-21):
disciplina la responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato;
Titolo V (artt. 22-31):
si introducono misure per l’economia dello spazio, introducendo un nuovo strumento di durata quinquennale, denominato
Piano nazionale per l’economia dello spazio a cui si accompagna l’istituzione di un fondo specifico finalizzato a promuovere l’innovazione tecnologica, sviluppo produttivo e valorizzazione commerciale
.
Una delle innovazioni che il Ddl afferma di presentare è di colmare l’assenza di una competenza UE in materia di armonizzazione delle legislazioni spaziali nazionali. Infatti, tra le criticità evidenziate nella nota allegata al Ddl da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, troviamo l’assenza di meccanismi autorizzativi e di vigilanza sulle operazioni spaziali oltre all’assenza di meccanismi sanzionatori e gestione dei rischi delle operazioni spaziali. Per tali ragioni, spiega il MIMIT, non era possibile per gli operatori spaziali, operanti sul territorio italiano, avere un accesso e un controllo sullo spazio il che portava, automaticamente, ad escluderli ed a limitarli rispetto ai competitor internazionali. I meccanismi di vigilanza determinati nel Disegno di legge mirano, dunque, a superare le criticità naturali di un’attività così complessa e questi, accompagnati dal sistema sanzionatorio presentato, saranno finalizzati a supportare un sistema di prevenzione contro il rischio di abusi delle operazioni spaziali.
Possiamo quindi tentare di riassumere brevemente gli obiettivi specifici individuati dal Disegno di legge in singoli punti suddivisi in tre macroaree:
A) MECCANISMI AUTORIZZATORI
1. Definizione di un regime autorizzatorio delle attività spaziali indipendentemente dalla nazionalità dell’operatore interessato a cui segue l’individuazione delle fasi del procedimento autorizzatorio che deve essere presentato all’Autorità responsabile e successivamente accertato dall’Agenzia spaziale italiana (ASI). Un’analisi comparata con altre Nazioni mostra che, in molti casi, l’autorizzazione è rilasciata dai ministeri competenti con le Agenzie nazionali con funzione di supporto tecnico. Il Ddl in esame, invece, prevede un sistema più articolato che prevede il coinvolgimento dell’Autorità responsabile (Presidente del Consiglio o autorità delegata), dell’ASI e del Comitato interministeriale per le politiche aerospaziali (COMINT)
2. Le autorizzazioni rilasciate non presentano una durata fissata (a differenza di altri Stati che generalmente fissano una durata di 20 anni) e possono essere sia per singola attività che per serie di attività (anche questo elemento di distacco rispetto ad altri Stati come UK, Giappone, Belgio, Sudafrica, Svezia, Olanda, Norvegia e USA).
3. Semplificazione della disciplina mediante l’introduzione in un unico corpus normativo delle disposizioni in materia
B) MECCANISMI DI VIGILANZA E SANZIONATORI
4. Razionalizzazione del tema delle responsabilità. Il Disegno di legge stabilisce che l’operatore dovrà rispondere dei danni causati nell’esercizio dell’attività spaziale nei limiti dei massimali assicurativi. Il Disegno di legge, come una delle forme di sostegno delle attività spaziali, garantisce l’assunzione da parte dello Stato della garanzia sovrana oltre il limite stabilito dalla legge per i massimali, come nel caso degli Stati Uniti. Negli USA troviamo una garanzia fino ai 1,5 miliardi (secondo il concetto della Maximum Probable Loss), in Francia tra i 50 ed i 70 milioni – il Disegno di legge propone un sistema con responsabilità limitata dell’operatore fino al massimale assicurativo di 100 milioni per sinistro.
5. Per il motivo osservando al punto 4. il Disegno di legge impone la stipula di una garanzia assicurativa (o finanziaria) per la copertura dei danni causati.
6. Responsabilità civile dell’operatore e dello Stato. In tema di responsabilità civile dell’operatore, in coerenza con il diritto internazionale, il Ddl prevede la responsabilità assoluta dell’operatore in caso di danni sulla superficie terreste o aeromobili in volo e si rimanda alle norme del Codice civile. Per quanto concerne la responsabilità civile dello Stato, il Ddl segue la Convenzione sulla responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 al cui articolo III
prevede la responsabilità dello Stato di lancio per tutti i danni cagionati in luoghi diversi dalla superficie terrestre o ad aeromobili in volo.
7. Consapevole della diffusione, in questo settore come in altri, di molte PMI il Disegno di legge promuove le attività delle piccole e medie imprese dettando norme speciali in materia di appalti e sostegni per le PMI e startup innovative
8. Attività di monitoraggio ex post, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, sulla base dei risultati ottenuti con l’attuazione dell’intervento normativo su vari ambiti dal numero di sanzioni (amministrative e/o penali) ad uno stesso soggetto, al numero di contratti stipulati, posti di lavoro generati/persi, oltre a più noti indicatori finanziari.
C) PIANIFICAZIONE ECONOMICA
9. Il Ddl in esame propone un Piano nazionale e un Fondo dedicato per promuovere l’economia spaziale
Conclusioni
Il Disegno di legge Spazio, uno dei primi in Europa ed il primo in Italia non trova però soltanto elementi a suo favore. Come leggiamo fin dal titolo, a volte essere i primi porta a voler velocizzare le proprie ricerche ed analisi per garantirsi il primato con la conseguenza di non coprire tutti gli elementi essenziali. A tal proposito, nell’audizione del Presidente di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) l’Avv. Pierluigi di Palma evidenzia una mancanza nel Ddl che non riporta nessun accenno al volo suborbitale e non viene chiarita una definizione di spazioporto nonostante risultassero nei lavori preparatori e nelle bozze del COMINT. In tale relazione, viene sottolineata l’importanza del volo suborbitale quale possibile strumento nel prossimo futuro per applicazioni sia di carattere civile che militare – permette un trasporto intercontinentale punto-punto ad altissima velocità con possibilità di collegare due punti qualsiasi del globo in temi rapidissimi entro le circa due ore. Ad esso si aggiunge la riduzione delle emissioni lungo la rotta nelle fasi in cui non è necessaria alcuna forma di propulsione potendo, il velivolo, muoversi “per gravità”. Tali tipologie di velivoli, però, non operano secondo mezzi spaziali quali si è solito immaginare, soprattutto quelli a decollo e atterraggio orizzontale. Questo ci porta ad avvicinarci quindi all’interpretazione degli aerei “tradizionali” e quindi potrebbe crearsi un conflitto normativo tra la normativa già in uso e quella, al momento assente, per i velivoli suborbitali. Inoltre, altro tema complesso è proprio nella definizione di “suborbitale” a livello normativo. Secondo l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) definiamo per volo suborbitale un volo che raggiunge quote molto elevate senza entrare in orbita attorno alla Terra. Sulla stessa linea EUROCONTROL lo chiarisce come volo intenzionale che supera le quote raggiunte dai velivoli tradizionali a propulsione atmosferica senza raggiungere la velocità orbitale. Anche l’Avv. Giovanni Mastroianni nel suo quaderno per l’associazione AISDUE riconosce la totale assenza di un riferimento esplicito a mezzi suborbitali osservando che, se volessimo interpretare la norma, potremmo pensare che il riferimento sia nella lettera a) dell’art. 2 in cui si parla di “razzi sonda” e “piattaforme stratosferiche”. Ora, i razzi sonda però hanno una caratterizzazione tecnica che ci porta a rientrare nelle questioni giuridiche dell’Outer Space Treaty operando prevalentemente in spazio extra-atmosferico e raggiungendo quote molto elevate fino ai 1500 km di altitudine. Allo stesso tempo le piattaforme stratosferiche non possono essere interpretate come (anche) mezzi per volo suborbitale in quanto altrimenti entrerebbe in conflitto l’interpretazione giuridica con quella tecnico scientifica. Infatti, la stratosfera ricomprende quote tra i 15 ed i 50 km, fascia all’interno della quale si muovono diversi mezzi sia civili che militari al contrario dei mezzi suborbitali che superano la soglia dei 100 km per poi tornare di nuovo a terra. Il problema va dunque chiarito e non possiamo aspettarci una normativa differenziata tra il volo civile e quello spaziale, in quanto la Convenzione di Chicago non definisce chiaramente un limite tra spazio aereo e spazio esterno ma si tratta solo di un limite tecnico. Il volo suborbitale rompe però questa limitazione tecnica e quindi, in tal caso, già possiamo anticipare la necessità di nuove aggiunte legislative su tale tema in futuro o anche nella prossima discussione in Parlamento. È indubbio, dunque, che l’ENAC si trovi in una situazione di diretto interesse di cui bisogna tenere considerazione; qualora il legislatore vorrà attribuire questo tipo di operazioni al Ddl Spazio si creerebbe un cambio di governance e gestione amministrativa che potrebbe “sottrarre” ad ENAC il ruolo che essa si è costruito nel corso di questo tempo, ad esempio, con il Governo USA e l’azienda statunitense Virgin Galactic. Per tale ragione, l’ENAC proporrebbe una modifica dell’art. 2 aggiungendo delle definizioni di “attività spaziale”, “attività suborbitale”, “operatore suborbitale” e “spazioporto” al momento assenti nella disciplina a cui si aggiunge la proposta di un ulteriore articolo ad hoc (il 14-bis) da dedicare esclusivamente alle attività suborbitali. Ecco che torniamo, quindi, alla rischiosa dicotomia tra sviluppo e burocratizzazione. Lo stesso Giorgio Marsiaj, Delegato del Presidente di Confindustria per l’Aerospazio, in una sua audizione davanti alla Commissione della Camera per le attività produttive, commercio e turismo sottolinea “come raccomandazione generale” come la legge non debba ingessare o complicare l’operatività delle imprese o creare nuove barriere all’ingresso. L’obiettivo quindi, come suggerisce Marsiaj, deve essere quello di definire delle linee guida fondamentali da integrare in momenti successivi sulla base delle evoluzioni del settore e del panorama normativo europeo.
In conclusione, quindi, il Governo Meloni ha tentato a suo modo di rispondere alla domanda-titolo di questa analisi – essere i primi o essere i migliori?
A mio avviso, nello studio dei documenti per questa analisi, ho riscontrato un parallelismo con un modello di microeconomia noto come “Economia di Robinson Crusoe”. Questo modello, che si basa sulla scelta produttiva di un singolo agente economico, prende spunto dalla storia di Daniel Defoe in cui il protagonista, Robinson Crusoe, si trova su un'isola deserta e deve decidere come allocare il proprio tempo e le proprie risorse limitate: raccogliere noci di cocco per soddisfare il suo bisogno di cibo (massimizzare il profitto) o riposarsi per migliorare il suo benessere (massimizzare l’utilità). La situazione di Robinson, dunque, diventa un esempio di scelta intertemporale: deve decidere se “consumare” nel presente, ottenendo i benefici immediati di raccogliere i cocchi, oppure se risparmiare, con l’idea di ottenere un maggiore benessere in futuro.
Nel presentare il Ddl Spazio il Governo italiano si è trovato, dunque, di fronte a una decisione simile a quella di Robinson: se agire velocemente per inserirsi in un mercato in rapida evoluzione, con il rischio di una legislazione imperfetta e che necessiti di aggiustamenti futuri, oppure se attendere una più precisa regolamentazione europea, con il rischio di rimanere indietro rispetto agli altri attori internazionali. La scelta di “anticipare il consumo” del Ddl Spazio rappresenta, un esempio di decisione intertemporale in un contesto estremamente accelerato, trainato altresì da un contesto geopolitico molto pressante – il Governo ha scelto così di non aspettare, temendo che ritardi legislativi potessero compromettere la competitività delle imprese e la posizione dell'Italia in un settore cruciale per il futuro. Questa decisione, pur se coraggiosa, non è priva di rischi. Infatti, come nel caso di Robinson Crusoe, c’è sempre il rischio che un’azione tempestiva, pur nella sua incompletezza, possa portare a dover fare i conti con il futuro, adattandosi a modifiche o nuove esigenze legislative. Il Governo ha preferito quindi affrontare il rischio di un Ddl incompleto ora, piuttosto che trovarsi, in futuro, tagliato fuori dal panorama internazionale della space economy, un rischio che sarebbe stato troppo alto da correre. Su questa stessa linea, quindi, osserviamo che non esistono scelte sbagliate ma solo scelte più consapevoli e meno consapevoli. Dunque, sarà necessaria una mentalità aperta ed una capacità di analisi che permetta al sistema legislativo di adattarsi al meglio alle future evoluzioni del settore.
Italy and its Ddl Spazio:
To Be the First or to Be the Best?
By Riccardo Morelli
April 1st, 2025
Abstract
The Ddl Spazio, the first Italian bill on the space economy, addresses a complex geopolitical and regulatory context, marked by a rapid evolution of the space sector and unprecedented global challenges. The Italian Government is aware of the role this sector can have both for National Security and industrial development – thus, a dilemma arises between taking the risk of a first national regulation or waiting for a more defined European legislation, with the risk of falling behind.
Introduction
The Ddl Spazio enters the Chamber of Deputies for its approval: the discussion is heated, and the first Italian initiatives to regulate one of the world’s fastest-growing sectors hang in the balance. However, the Montecitorio Chamber decides to approve, with 133 votes in favour (89 against and 2 abstentions), the first Bill on the space economy. The ball will now pass to the Senate for its final approval and will, in fact, represent the first legislative measure, at the national level, aimed at regulating the sector.
The issue is complex, and there are no comments on it. Regardless of how one chooses to interpret the document’s text, it is still a first attempt: some parts will be content and others dissatisfied, only time will teach us how best to evolve. The sector that the Ddl seeks to define is still very much (perhaps too much) opaque – it is impossible to provide a unified estimate of the value of the space sector. The actors involved are many, and the players are divided into private and public entities. Moreover, the states themselves also represent one of the categories of consumers of these technologies, which find applications both in civilian and intelligence contexts. This distinction is not secondary: regulating a private activity where one of the main consumers is the state itself, for National Security purposes, risks creating a vicious circle that leads to a self-generated slowdown of our control capabilities.
This analysis aims, therefore, to clearly highlight the national and international context in which the Ddl Spazio is inserted, without rushing to judge what its developments might be.
The Geopolitical Context
To understand the Bill, we must take a step back to a few years ago. In the post-pandemic period, Italy witnessed the start of a very complex political game that led to the end of the Conte II Government, which was replaced by the Draghi Government (2021-2022). It was precisely during this phase that COPASIR published the results of an internal research titled Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica (Report on the Aerospace Domain as a New Frontier of Geopolitical Competition), which stated, in the introduction, the reasons that motivated the study: "The Committee deemed it necessary to conduct a specific inquiry into the aerospace domain, initiated concurrently with another inquiry regarding the development prospects of European common defence and cooperation between intelligence services." This report, as evident in the introductory pages of the Bill, represents the foundational basis on which the new Meloni Government (which delegated Minister Urso, President of COPASIR at the time of the aforementioned report, to the themes of space in Italy) demonstrated the urgent need to create European regulation (and, in the meantime, an internal Italian regulation) on space to protect businesses and intelligence uses. The Italian economic situation in 2022 was surrounded by a slight post-Covid recovery, but still lower than pre-pandemic rates. Despite this, space has never been sidelined, in fact, Italy is one of the most advanced countries in the world: it is the third largest contributor to ESA (after France and Germany) and the sixth largest space industry globally, and one of the few countries with a complete production chain within its borders. Additionally, Italy has advanced technical expertise in satellite construction and data processing technologies. Despite this, in space, as in other areas of our political history, Italy experiences the paradoxical dichotomy between industrial excellence and bureaucratic backwardness – young businesses risk failing before they can spread their products internationally; however, all analysts and politicians, regardless of their orientation, have understood that this, for the space sector, cannot happen: it is too important. The Space domain is increasingly playing a role in safeguarding the defence and security of nations, territories, people, the environment, and infrastructures. For these reasons, new challenges arise not only for the world order but also for Italy's National Defence. Therefore, COPASIR observes that for Italy, a challenging task presents itself, which requires reflection on alternative methods to be used in providing space infrastructure and products – we must protect our businesses, create a European network that does not imply limitations on intelligence controls, and limit the risks of Chinese successes.
However, Italy had already clearly understood the importance of space even before the 2022 COPASIR report; in fact, the Law of January 11, 2018, No. 7, had intervened initially to adjust space governance. Thanks to this law, the Prime Minister is entrusted with the high direction and coordination of the Space and Aerospace Policies of the Ministries, and the Interministerial Committee for Space and Aerospace Research Policies (COMINT) was established – currently chaired by the Minister for Enterprises and Made in Italy Adolfo Urso, as the authority delegated by the Prime Minister, along with various figures, including the President of the Italian Space Agency (ASI) Teodoro Valente.
In the recent dossier Disposizioni in materia di economia dello spazio (Provisions on Space Economy), the acceleration induced by the geopolitical and geoeconomic context is made explicit. In particular, it is written that the "rapid decoupling between the USA and China [...] (reinforces) the idea that two dominant world blocs are emerging, with a possible return to a Cold War situation." The Bill presented to the Chamber, therefore, must be read considering an observation of the global political situation. For example, the transition from Biden's presidency to Trump's presidency (still unknown at the time of the Dossier) upends the interpretation of international law that has been discussed so far because no agreement, meeting, or treaty (for the foreseeable future) can ignore the first world economy. Regional regulatory frameworks, such as Europe’s, could thus gain strength and turn into opportunities for acquiring autonomy in the hope of future self-sufficiency. Such observations may have been one of the reasons that convinced lawmakers to approve the Bill in question. The uncertain position of NATO and the initiation of an anti-multilateralism American administration open the door to new diplomatic, economic, and industrial scenarios.
To understand the context in which the Ddl Spazio is inserted and what the direct or indirect pressures were that pushed the Government to present a Bill on such an evolving subject, we must necessarily look beyond national law. On the global stage, we find various anomalies that lead to an overcrowding of norms, some signed by many states, others with fewer participants, generating significant confusion – it is within this confusion that private players are pushing the accelerator.
Let us begin with the highest possible recognition, in my personal opinion, of the importance of space in the world of defence: NATO has defined Space as the fifth collective domain for which Article 5 of the Treaty can be triggered. This means that space missions take on new diplomatic importance (referred to as space diplomacy) in the wake of other treaties signed in recent history that form what is known as the Corpus Juris Spatialis. Space, in fact, even before bringing economic excitement, generated strong fears among post-World War II policymakers about the possible repercussions. For this reason, as early as 1967 (two years before Apollo 11 landed on the Moon), the first international space treaty was signed, known as the "Outer Space Treaty" – this first regulation prohibits placing nuclear weapons or any other type of mass destruction weapons in Earth’s orbit, on the Moon, or other celestial bodies, or stationing them in outer space. Other essential points of the Outer Space Treaty include the prohibition of testing any type of weapons, conducting military manoeuvres, or establishing military bases (installations or fortifications), as well as the prohibition of claiming resources located in Space, such as the Moon, a planet, or another celestial body. Here, a brief reflection on current issues reveals the legal complexity of asteroid mining, where, along these lines, any material acquired would be "owned" by humanity and not by the private individual or state that conducted the mission. The Corpus Juris Spatialis took shape in subsequent years, with the signing of four other treaties, the last of which, known as the Moon Treaty, aimed at regulating activities on our natural satellite, such as resource extraction, was ratified by only 18 states, notably absent being the United States, Russia, and China.
The European Union also clearly understands the importance of space, and it is not just a recent topic, as one might imagine. As early as 2009, Article 189 of the TFEU stated that the European Union develops a space policy to "promote technical and scientific progress, industrial competitiveness, and the implementation of its policies." 2016 was the year when the Space Strategy for Europe was launched with the aim of boosting the EU’s industrial development with four main objectives:
- Encouraging the commercial use of space data and services by both public and private sectors;
- Supporting Research and Innovation;
- Strengthening European autonomy in access to and use of space;
- Strengthening Europe’s role as a global actor in international cooperation.
Intellectual honesty leads us to observe that these objectives are as interesting as they are vague, but, in defence of the European Parliament, we must recognize that, by 2016, no one had a clear idea of how this sector would develop. Just think that the first successful vertical landing of the American SpaceX took place on December 22, 2015, and nine years later, we have seen 138 successful launches in 2024 alone, with all the implications that such a result brings. In general, Europe tries to smooth out its delay with long-term plans, promoting medium-long term goals and missions to avoid overloading businesses and causing too much disruption to national administrations; likewise, in space, in 2021, the European Council revised the Space Strategy for the 2021-2027 period. However, it must be remembered that this time span is embracing radical political shifts worldwide. In America, the administration has shifted from Biden to Trump, with Elon Musk as a prominent ally, but not only. Italy has seen a government more favourable toward space missions, even though historically, centre-right parties have been more hostile to spending in this sector. On this line, we also saw a change in the NATO Secretary General from Stoltenberg to Mark Rutte. New political leaders are also taking over in their countries, such as in Germany, Greenland, and Canada. All of this is happening without mentioning the space missions that have taken place in this time span: the Indians who landed on the Moon for the first time, confirming their strong technical-scientific reality, the Chinese who reached the far side of the Moon for the first time, and the successes of private companies, such as Elon Musk’s Starship, which could be a trump card for the USA in their race against China. Of course, space dynamics are directly influenced by geopolitical tensions, and since the European plan began in 2021, the world has witnessed the start of the war in Ukraine (2022), the Gaza war (2023), and the ever-tense border with Taiwan. This is why, in Europe, before Italy, one must always ask: is it always better to be first? The "halfway point" of the European Space Plan 2021-2027 has just passed, and these are the events of the past three years, events that could not have been predicted and that, however, change the needs of consumers, actors, and national, European, and extra-European regulatory requirements. Would it still be correct to stick to those decisions?
This is the context in which the Meloni Government finds itself and in which it decided to make its move: proposing to Parliament the first Bill on the space economy.
The political-personal relationship that President Meloni has shown in recent times with Elon Musk immediately hinted that Italy is trying to carve out its own prominent role in the space sector. As we have observed, however, the governance of this industry is complex and intricate, oscillating between private profits and intelligence service interventions, with consequent limitations on the dissemination of strategic information.
In general, no space enthusiast can be completely opposed to Elon Musk, as, if these passions still make sense, they are certainly attributable to his vision, even if sometimes controversial. However, a different discourse must be made when stepping outside the media and historical sphere of Elon Musk to directly look at his companies, the activities carried out, and the power that could be delegated to them. An example is the alleged agreement that Meloni wanted to create with Elon Musk regarding the use of Starlink services, which was never explicitly discussed in Parliament. This perspective certainly changed its course after the March meeting-encounter between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Donald Trump in the Oval Office. This is not the place to analyse this meeting, but it should be noted as one of its consequences, regardless of any political stance: Elon Musk threatened the Ukrainian President to cut off Starlink services, used by Ukrainian military personnel, if Zelensky did not sign the agreement proposed by the American President. The diplomatic strategy is valid, but the method is unusual – it’s a private individual, against a President, who can influence the course of a war. The rest, as they say, is history, with the consequence that Ukraine lost positions in Kursk (Russia), which it had previously captured in an uncertain situation, and which it wanted to use, in a peace table with Russian President Putin, as a bargaining chip or, in any case, a position in its favour.
This is where the title of this analysis becomes relevant again; we cannot know whether using Starlink services for the Italian Government is or will be a strategically effective move, but we certainly cannot overlook, in future assessments, the recent events.
All of this represents the context in which this Bill seeks, in its own way, to enter for the first time. Even in the opening of the Bill, the role of the paradigm shift generated by the entry of private actors is expressed, which, as stated, "marks a shift in regulation, which moves from international public law to permeating national public law and private law." This means that any evaluation of the individual provisions is null in such a mutable sector, and only time will teach us how to direct our legislation in this field.
The Ddl Spazio – Main Elements
Now, given the context presented, let us look at the main points of the Bill. To analyse its structure in detail, we can start with the opinion of the I Permanent Committee for Constitutional Affairs of the Presidency of the Council and Interior Affairs to see which areas of interest, in its view, are touched upon by the Bill: "foreign policy and international relations of the state," "defence and armed forces," "state security," "protection of competition," "organization and administrative organization of the state and national public bodies." This report clearly shows that "the objective of the provision, consisting of 31 articles divided into five titles, is to fill the regulatory gap in the national legal system concerning space activities, promoting the growth of the Italian space industry and technological innovation, as well as strengthening international cooperation”. Still analysing the opinions of the Permanent Committees, it is interesting to note the preamble of the II Permanent Committee on Justice, which recognizes the interest of the Bill as a strategic crossroads of geopolitical, economic, scientific, and military interests. We also observe that neither the VI Permanent Committee (Finance), nor the VII Permanent Committee (Culture, Science, and Education), nor the IX Permanent Committee (Transport, Posts, and Telecommunications) have expressed any considerations, voting in favour of the Bill (as did the other Committees).
The objective is therefore very clear, and the Meloni Government aims to achieve it on five areas of interest:
Title I (articles 1-2):
general provisions on space;
Title II (articles 3-14):
identifies the objective and subjective requirements necessary for authorization to carry out space activities. Along the same lines, the administrative and criminal sanctions system related to the procedure is defined;
Title III (articles 15-17):
focuses on the registration of space objects;
Title IV (articles 18-21):
regulates the responsibility of space operators and the state;
Title V (articles 22-31):
introduces measures for the space economy, establishing a new five-year tool, called the National Space Economy Plan, accompanied by the creation of a specific fund aimed at promoting technological innovation, productive development, and commercial valorisation.
One of the innovations that the Bill claims to present is filling the gap of a European competence in harmonizing national space legislations. In fact, among the critical issues highlighted in the note attached to the Bill by the Ministry of Enterprises and Made in Italy, we find the lack of authorization and monitoring mechanisms for space operations, as well as the absence of sanctioning mechanisms and management of space operations risks. For these reasons, the Ministry of Enterprises and Made in Italy (MIMIT) explains that it was not possible for space operators operating on Italian territory to have access to and control over space, which automatically excluded them and limited them compared to international competitors. The monitoring mechanisms defined in the Bill aim to overcome the natural complexities of such an activity, and these, along with the sanctioning system presented, will be aimed at supporting a preventive system against the risk of abuses in space operations.
We can therefore try to briefly summarize the specific objectives identified by the Bill in individual points, divided into three macro-areas:
A) AUTHORIZATION MECHANISMS
1. Definition of an authorization system for space activities regardless of the nationality of the operator involved, followed by the identification of the phases of the authorization process, which must be presented to the responsible authority and subsequently verified by the Italian Space Agency (ASI). A comparative analysis with other nations shows that, in many cases, authorization is granted by competent ministries with national agencies serving as technical support. The Bill in question, however, provides for a more articulated system involving the responsible authority (Prime Minister or delegated authority), ASI, and the Interministerial Committee for Aerospace Policies (COMINT).
2. The authorizations granted do not have a fixed duration (unlike other countries that generally set a duration of 20 years) and can be for single activities or a series of activities (this also marks a departure from other countries such as the UK, Japan, Belgium, South Africa, Sweden, the Netherlands, Norway, and the USA).
3. Simplification of the discipline by introducing in a single regulatory framework the provisions concerning space activities.
B) MONITORING AND SANCTIONING MECHANISMS
4. Rationalization of the responsibility issue. The Bill establishes that the operator must be liable for damages caused in the exercise of space activities within the limits of insurance caps. The Bill, as one form of support for space activities, ensures that the state will assume sovereign liability beyond the legally established caps, as is the case in the United States. In the USA, there is a guarantee up to 1.5 billion (according to the concept of Maximum Probable Loss), in France between 50 and 70 million – the Bill proposes a system with limited operator liability up to an insurance cap of 100 million per incident.
5. For the reason observed in point 4, the Bill requires the signing of an insurance (or financial) guarantee for coverage of the damages caused.
6. Civil liability of the operator and the state. Regarding the civil liability of the operator, in line with international law, the Bill provides for absolute liability for the operator in case of damage to the earth’s surface or to aircraft in flight, referring to the provisions of the Civil Code. As for the civil liability of the state, the Bill follows the 1972 Convention on Liability for Damage Caused by Space Objects, Article III of which holds the launching state liable for all damages caused in places other than the earth’s surface or to aircraft in flight.
7. Aware of the prevalence of many SMEs in this sector, the Bill promotes the activities of small and medium-sized enterprises by setting special rules for contracts and support for SMEs and innovative startups.
8. Post-event monitoring by the Ministry of Enterprises and Made in Italy based on the results obtained from implementing the regulatory intervention across various areas, including the number of sanctions (administrative and/or criminal) on the same subject, the number of contracts signed, jobs created/lost, as well as other well-known financial indicators.
C) ECONOMIC PLANNING
9. The Bill proposes a national plan and a dedicated fund to promote the space economy.
Conclusions
The Space Bill, one of the first in Europe and the first in Italy, does not, however, find only elements in its favour. As we read from the title, sometimes being the first leads to speeding up research and analysis to secure the lead, with the consequence of not covering all the essential elements. In this regard, in the hearing of the President of ENAC (National Civil Aviation Authority), Avv. Pierluigi di Palma highlights a gap in the Bill, which does not mention suborbital flight and fails to clarify the definition of spaceport, even though these were included in the preparatory works and drafts of COMINT. In this report, the importance of suborbital flight is emphasized as a possible tool in the near future for both civil and military applications – it allows for intercontinental point-to-point transportation at very high speeds, with the possibility of connecting any two points on the globe in extremely rapid times, within about two hours. It also includes the reduction of emissions along the route during phases where no propulsion is needed, allowing the aircraft to move "by gravity." However, these types of aircraft do not operate according to space vehicles as commonly imagined, especially those with horizontal take-off and landing. This leads us to approach the interpretation of "traditional" airplanes, and therefore a regulatory conflict might arise between the regulations already in place and the current absence of regulations for suborbital aircraft. Moreover, another complex issue is the very definition of "suborbital" at the regulatory level. According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), a suborbital flight is defined as a flight that reaches very high altitudes without entering orbit around the Earth. Similarly, EUROCONTROL clarifies it as an intentional flight that exceeds the altitudes reached by traditional atmospheric propulsion aircraft without reaching orbital speed. Also, Avv. Giovanni Mastroianni, in his notebook for the AISDUE association, acknowledges the complete absence of an explicit reference to suborbital vehicles, noting that if we were to interpret the regulation, we might think the reference lies in letter a) of Article 2, where "sounding rockets" and "stratospheric platforms" are mentioned. However, sounding rockets have a technical characterization that leads us to the legal issues of the Outer Space Treaty, operating primarily in outer space and reaching very high altitudes, up to 1500 km. At the same time, stratospheric platforms cannot be interpreted as (also) means for suborbital flight because doing so would create a conflict between the legal and technical-scientific interpretation. In fact, the stratosphere covers altitudes between 15 and 50 km, within which various civil and military vehicles move, unlike suborbital vehicles that exceed the 100 km threshold and then return to Earth. The problem, therefore, needs to be clarified, and we cannot expect differentiated regulations between civil and space flight, as the Chicago Convention does not clearly define a boundary between airspace and outer space, but it is merely a technical limit. However, suborbital flight breaks this technical limitation, and therefore, in this case, we can already anticipate the need for new legislative additions on this topic in the future or even in the next discussion in Parliament. It is therefore undeniable that ENAC finds itself in a situation of direct interest that must be taken into account; if the legislator decides to assign these types of operations to the Space Bill, it would create a change in governance and administrative management that could "take away" from ENAC the role it has built over time, for example, with the US Government and the American company Virgin Galactic. For this reason, ENAC would propose an amendment to Article 2, adding definitions of "space activity," "suborbital activity," "suborbital operator," and "spaceport," which are currently absent in the regulations, along with the proposal for an additional article (14-bis) dedicated exclusively to suborbital activities. Here we return to the risky dichotomy between development and bureaucratization. The same Giorgio Marsiaj, President's Delegate for Aerospace at Confindustria, in his hearing before the Chamber's Committee for Productive Activities, Commerce, and Tourism, emphasizes "as a general recommendation" that the law should not hinder or complicate the operations of businesses or create new barriers to entry. The goal, as Marsiaj suggests, should be to define fundamental guidelines to be integrated at later stages based on sector developments and the European regulatory landscape.
In conclusion, therefore, the Meloni Government has tried, in its own way, to answer the title question of this analysis – to be the first or to be the best?
In my opinion, in studying the documents for this analysis, I found a parallel with a microeconomic model known as the "Robinson Crusoe Economy." This model, based on the production choice of a single economic agent, takes inspiration from Daniel Defoe's story, where the protagonist, Robinson Crusoe, finds himself on a deserted island and must decide how to allocate his time and limited resources: gather coconuts to meet his food needs (maximize profit) or rest to improve his well-being (maximize utility). Robinson's situation thus becomes an example of intertemporal choice: he must decide whether to "consume" in the present, gaining the immediate benefits of gathering coconuts, or to save, with the idea of achieving greater well-being in the future.
In presenting the Space Bill, the Italian Government found itself facing a decision similar to Robinson's: whether to act quickly to enter a rapidly evolving market, with the risk of imperfect legislation that may need future adjustments, or to wait for more precise European regulation, with the risk of falling behind other international players. The choice to "anticipate consumption" of the Space Bill represents an example of intertemporal decision-making in an extremely accelerated context, also driven by a very pressing geopolitical environment – the Government chose not to wait, fearing that legislative delays could compromise the competitiveness of businesses and Italy's position in a crucial sector for the future. This decision, though courageous, is not without risks. In fact, as with Robinson Crusoe, there is always the risk that timely action, despite its incompleteness, may lead to having to deal with the future, adapting to modifications or new legislative needs. The Government, therefore, preferred to face the risk of an incomplete Bill now, rather than find itself, in the future, excluded from the international space economy landscape, a risk that would have been too high to take. Along the same lines, we observe that there are no wrong choices, only more aware and less aware choices. Thus, an open mindset and the ability to analyse will be necessary for the legislative system to best adapt to the future evolutions of the sector.
Bibliografia
Camera dei Deputati - X Commissione (Attività produttive, c. e. (2024, Dicembre 3). DDL A.C. 2026 Disposizioni in materia di economia dello spazio - Audizione Presidente ENAC (Av.. Pierluigi di Palma). Tratto da https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM10/Audizioni/leg19.com10.Audizioni.Memoria.P...
Camera dei Deputati. (2024, Ottobre 29). Disposizioni in materia di economia dello spazio (Dossier n.388). Tratto da Dossier XIX Legislatura: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AP0163.pdf
COPASIR. (2022, Luglio 07). Relazione sul Dominio Aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica. Tratto da https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicam...
Deputati, C. d. (2025, Marzo 06). Approvato disegno di legge su economia dello spazio. Tratto da https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-47534
Marsiaj, G. (2024, Dicembre 04). Raccomandazioni in merito al Disegno di Legge sullo Spazio. Tratto da CONFINDUSTRIA: https://www.confindustria.it/wcm/connect/c80aef68-fa06-42cc-a6ec-8f99ab184fb2/Audizione+Confindustri...
Mastroianni, G. (2024, Agosto 29). Il DDL Spazio italiano: le nuove governance, il dubbio sulla disciplina dei voli suborbitali e l'allontanamento dal modello USA. Tratto da Associazione Italiana Studiosi Diritto dell'Unione Europea (AISDUE): https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2024/08/Post-Giovanni-Mastroianni-2.pdf
Skytg24. (2025, Marzo 06). Ddl Spazio, via libera dalla Camera con 133 sì. Il testo passa al Senato. Tratto da https://tg24.sky.it/politica/2025/03/06/ddl-spazio-camera
Théard-Jallu, C., Péchon-Joubert, F. L., Cesari, L., & Destal, F. (2024, Luglio 11). Space Law 2024 (France). Tratto da Chambers and Partners: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/1223/13637/21691-21692-21693-21694-21...
Riccardo Morelli
Riccardo, neolaureato in Economia e Management presso la LUISS Guido Carli con una tesi su “Analisi geoeconomica della Space Economy”, collabora attualmente con il team di SPHERE del Center for International and Strategic Studies (CISS) della LUISS. Il suo principale interesse è focalizzato sulla valutazione degli scenari macroeconomici e sull'impatto delle tecnologie spaziali, con particolare attenzione alle loro implicazioni economiche, sociali e normative. Attualmente, Riccardo lavora a stretto contatto con associazioni e team multidisciplinari, con l'obiettivo di acquisire competenze in ambito militare, sicurezza, geopolitica e tecnico-scientifici


